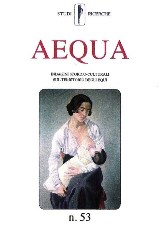Lo studioso rovianese di storia locale Artemio Tacchia ci ha gentilmente fornito alcune notizie su questo personaggio di cui si conosce pochissimo: Vincenzo Anivitti, erudito romano (nel libro di G. Silvestrelli,
Città castelli e terre della regione romana, v. I, Roma, 1940, p. 361 viene chiamato D. Vincenzo Anivitti: probabilmente quindi il nostro era un sacerdote), scrive negli anni tra il 1845 e il 1858 vari articoli sui centri della Valle dell'Aniene, in particolare su Roviano. Probabilmente frequentava il paese perché imparentato, per via materna, con la famiglia locale dei Parisi. Possedeva dei fondi che dava in affitto a contadini rovianesi. Dal 1868 al 1875 un Anivitti Paolo riceveva da Luigi Scacchi 60 baiocchi di canone per non meglio precisati servizi o affitti. Un Filippo Anivitti (1876-1955), figlio di Raffaele, pittore e acquarellista romano del gruppo dei "XXV della campagna romana", aveva lo studio in via Margutta. Forse erano della stessa famiglia del nostro articolista. (questi dati li trascrivo da: A. Innocenzi, L. Verzulli,
S. Elia un monte una chiesa una casa, Subiaco, 2000, p. 37)
In L'Album di Roma, anno XII, 8 novembre 1845, p. 296:
AGLI AMATORI DELLA TOPOGRAFICA ANTICHITÀ
Cum nova toto quaerent,
nonnisi prisca peto.

Sotto i colli signoreggianti la valle, che al trigesimo quarto miglio della via sublacense si estende a dar più libero il corso ai tortuosi giri dell'Anio, prossimo alla moderna strada di Arsoli un ponte si asconde di quadrilateri massi costruito, sul cui strato contavansi venti due piedi e mezzo di lunghezza, di larghezza diciotto; e sul cui arco sembra che gravi un peso di secoli. Scotonico volgarmente si appella, Scutonico lo dissero il Fabretti, il Corsignani, il Revillas ed altri che ne fecero menzione o discorso; sebbene
Stratonico denominato lo abbia l'Olstenio. Ma se costui errò forse nella denominanza; non errò ponendolo su quella via, che di mezzo agli Equi fu aperta dal magnanimo lor vincitore; e poscia fin là si protrasse dove Atemo versa il tributo delle sue acque in seno all'Adriatico. E ben numerosi son gli argomenti onde l'eruditissimo Nibby ha saputo riconoscere la Valeria costeggiante l'orrido monte S. Elia, immaginata già dal Fabretti, e da chi mal seguivane in ciò l'opinione, a nullità di prove soddisfacenti, e segno d'immense difficoltà. Certo è che tal ponte mostra già in se stesso confermare che a quella via appartenesse: dappoichè il carro, che certo non l'avrebbe strisciato frequente se fosse stato ponte si un semplice diverticolo alle sorgenti dell'acqua Marzia (siccome conghietturò il Fabretti); e che dovette certo andar frequente per un sentiero di tanta agiatezza e commercio qual fu già la Valeria (gemente sotto i carichi accumulati) solenni vi ha improntate le sue vestigie. È noto peraltro come sulle pubbliche vie, le più frequentate in ispece, volean sepolcro gl'illustri nostri maggiori, onde esposti alla pubblica vista, più sicura che non altrove aspettassero un vale pietoso, cui negar non sapevagli il passaggero. Or da questo costume eziandio difender poteva l'Olstenio una vetusta lapida mortuaria; poi nello Scotonico ad oriente dissotterrata non ha di molto, e del seguente tenore
T. NUFIO.FELICIANO.
T. NVFIVS.FILEIVS
ET.NOLLEIA.SECVNDINA
FILIO.DVLCISSIMO
B.M.F.
Più recente però, il rinvenimento di quasi intieri scheletri umani, la tumulazione de' quali tutti presentava i caratteri dell'antica età, in un podere della occidentale parte al ponte vicino; e che pria dell'ineguale slavamento delle terre superiori facilmente si concepisce essere stato ad egual livello del ponte stesso; novella forza apprestavane all'argomento sostenitore dell'opinione, che già non piacque al Fabretti. Noi lo pubblichiamo; chè qualunque se n'abbia ad estimar la importanza, non potrà non arridere ai gentili animi ingenui che amando in tutto la verità, si piacciano interrogarne persino i savi, tristi reliquie dell'avita grandezza, che più non è. Molto più che si può quindi stabilire come il bivio della sublacense, e della Valeria, nè poi fosse alla stazione ad Lamnas, nè all'odierno diverticol di Arsoli; ma in un quasi medio punto tra questi. Potrà ancora ogni curioso investigatore assicurarsi delle ulteriori tracce della Valeria superstiti al di là dello stesso ponte, e ben distaccate dalla facile strada che oggi a quel culto borgo conduce. Quanto poi ai nomi di quelli, dei quali un ferro campeste involontario turbava improvvisamente - le quiete ossa sepolte - lungo una via oltremodo magnifica al par dell'Appia e della Latina; ma di cui oggi in qualche punto si contrasta persino la direzione; un rozzo sasso o spezzato neppure ce ne offriva memoria:
Così sebbene un tempo al tempo guerra
fanno l'opre famose; a passo lento
E l'opre e i nomi insieme il tempo atterra!
A. V.
In L'Album di Roma, anno XVIII, 17 maggio 1851, p. 96:
VARIETÀ
Volgono sei anni da che per amore delle antiche memorie tentai di argomentare la linea della magnifica strada Valeria dopo la stazione
ad lamnas rispondente al XIV miglio della via sublacense, come salisse poco a poco la prima curva de' colli di Roviano, per ricongiugnersi agevolmente col ponte or conosciuto sotto il titolo di s. Giorgio. Il certo si è che Roviano non merita di essere affatto obliato dagli studi archeologici. Nel 1847 mi si disse che presso il viottolo di Rovianello (antico castello diruto) erasi rinvenuta per caso una specie di vettina crepata e ricongiunta a code di rondine, e che intorno vi si vedeano tracce di fabbrica romana. Accorso senza indugio ebbi la dispiacenza di trovar fatto in minutissimi pezzi per sospetto di qualche tesoro, un
dolio di sodissima composizione di terra, largo e grosso da starne a paro con qualunque altro pregiato; siccome tosto mi piacque di farmene certo pel confronto delle misure prese di questo, e di alcuni su i quali tiene parola il Vinckelmanno. Per non so quale combinazione quel dolio era non pure della stessissima forma in che ci si figura in un rilievo illustrato dall'anzidetto archeologo il dolio di Diogene; ma per più di egual crepa e con eguale arte ricommesso a diversi punti, come il greco artista immaginato aveva quello del suo filosofo. Codesto vaso potè servire agli usi campestri o domestici di L. Rubrio o di chiunque fosse l'antico possessore del fondo
rubriano o
rubiano. Certi sassi ho anche osservato per que' dintorni, dal cui lavoro si apprende avere essi appartenuto a qualche ara o tempietto, o certo a qualche sepolcral monumento. Taccio di un
lacrimatoio, ritrovato, per caso anche questo, presso umane reliquie non molto lungi dal ponte scotonico sotto Roviano ad oriente: era in una pentola di terra rossa egualmente antica; e sia per la patina entro formatavi dalle lagrime, sia per la umidità della terra, la parete interna del vetro pareva incrostata a mercurio. Vorrei credere che la pentola fosse la insegna dell'arte in cui erasi forse distinto il sepolto, l'arte fittile, di cui faceano conto i nostri maggiori, prima che s'invogliassero de' vasi di Corinto argomenti di rimprovero ne' paradossi di Tullio.
V. Anivitti
In L'Album di Roma, 1 maggio 1858, pp. 83-5:
IL MONTE DI S. ELIA PRESSO SUBIACO
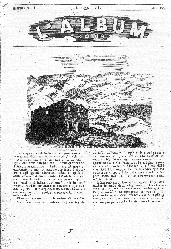
In tempi ne' quali tutto avea religiosa denominazione, più di un monte fu detto di
S. Elia. Non si sarebbe avvertito, fino col nome, che di gran lena fosse d'uopo a salirsi, simili quasi a quell'Oreb, alle cui falde il Tesbite ebbe ad essere riconfortato di angelico pane? o che lassù ti si aprirebbe agli sguardi interminato orizzonte, quale già dalle altezze del suo Carmelo al Profeta, e al garzone mandato da lui a spiare sulla punta degli ultimi sassi la simbolica nuvoletta? o che in quelle vette si sarebbe novellamente gustato lo Spirito di Dio,
Spirito d'aura leggera, come allora che Elia si coperse il capo del prodigioso suo manto, e disse - ecco Iddio?
Di tal genere sono i monti denominati di
Sant'Elia. Volendone discorrere storicamente, quello, del quale è qui ritratta l'ampia veduta dal punto in cui domina colli, e catene di altri monti all'intorno; dagli archeologi è appena accennato nella quistione della Via Valeria, sulla cui linea proponemmo altra volta (V. Album a. XIII. 8 nov. 1845, e a. XVIII 17 maggio 1851) certa nostra opinione, onde le carte topografiche potrebbero anzi tracciarla poco sotto Roviano, che non costeggiante questi scogli inaccessi.
Prima però che il tempo, distruggitor d'ogni cosa, sciolga le poche pietre, che, avanzo di fabbrica nel
medio-evo, appena resistono ancora perché legate da tale un cemento che uguagliava la forza di quelle guerresche generazioni; sarà bene che resti, qui almeno, descritto quel tanto che ancora ne stà in piè, e si sappia, per quando che sia, come lassù era un piccolo chiostro, ed una chiesuola (del che appunto il disegno ritrae le cadenti reliquie) il tutto intitolato a
Sant'Elia.
È certo che i monaci sublacensi possedettero un dì, e per corso di secoli, come tant'altro, così questi uomini, e questi paesi che sono su loro dossi, sulle lor cime, ne' lor dintorni. Niente dunque più facile che questo fosse un piccolo romitorio dove si ritraessero per vivere più solitari i migliori monaci, e specialmente in giorni ne' quali armi di ribaldi contrastavano loro il pacifico dominio di possessi creati di propria industria.
Al quale ritiro, se a noi fosse lecito avventurare una conghiettura [
sic] (e in cose archeologiche rare volte non s'avventura) vorremmo credere desse origine l'abate Elia, terzo dopo s. Benedetto, quando i saraceni distrussero affatto il monistero di Subiaco, e ne dispersero i monaci, (diciamo i pochi a' quali fu dato salvarsi la vita dalle loro scimitarre); terribile epoca dopo la quale non furono ricomposte le cose fino a Papa Giovanni, settimo di quel nome.
E tal epoca a cui risalghiamo [
sic] è notata negli Annali Benedettini (T. I. l. VIII. a. 593. pag. 210); i quali citano la Cronica sublacense, probabilmente quella che avrebbe voluto pubblicar Mabillon, e la pubblicata poi da Muratori (Rerum Italic. T. XXIV.); e gli uni e l'altra segnano il tremendo caso sotto il povero Elia. Oltre che il suo nome di Elia, unico fra gli abati sublacensi, potè facilmente suggerirgli l'idea di una solitudine sacra nel nome appunto di lui; è a por mente che se i saraceni misero a sacco e a rubba [
sic] Subiaco e la circostante Campagna, non però è fatto ricordo che con ugual furore si spignessero allora per questa altra parte, parte che per essere allora disabitata, dava maggior sicurezza a fuga e a nascondimenti. E ben difficile ad ogni conto il discoprire che là avesse ricoverato la vita, cioè al Monte di
Sant'Elia dove anche oggi non si rintana che qualche volpe, e non vi posa che qualche pernice. In seguito di tempo, riconquistate le possessioni primiere, e rifatto il monistero centrale (ciò che avvenne, come accennammo, sotto Giovanni VII), tornando i monaci a Subiaco, non però si sarebbe del tutto abbandonato il monte del rifugio; e così si spiegherebbe con molta naturalezza la origine del
Sant'Elia del qual favelliamo.
Certo è che riguardando di là a' sottoposti paesi (di cui non appaiono che Riofreddo, Poggio Ginolfo [
sic], Collalto, e il Vivaro) crederesti ancora vedere gl'incendî, gli eccidî, le fughe, le rivalse, i sanguinosi scontri de' tempifeudali ! Oimè ! Quanti delitti avranno contemplato da tali altezze i monaci abitatori di quelle crollanti pareti ! Oh come inorriditi doveano ritirare gli sguardi, e all'eco degli urli de' combattenti, e al sibilo delle frombole e al suon delle spade riparare, pregando, all'ombra delle celle, e degli altari di Dio ! Il Monte
Sant'Elia dovea porre sotto i loro occhi, quasi ci venne detto, i furori di nuovi Acabbi, quando gli Orsini, i Colonnesi, (e prima d'essi, e con essi, que' piccoli tiranni, che surti ogni giorno, ogni giorno usurpavano) perdevano, e si vendicavano alla lor volta !
Ma all'orrore di quelle reminiscenze sottentra ben presto un senso ineffabile di religione, ove ricordi che (probabilmente a spegnere le ire rivali de' due vicini paesi) quassù pellegrinavano due intere popolazioni, quella di Roviano, e quella di Riofreddo, i due al cui territorio appartiene, metà a metà, il
Sant'Elia. Era ciò a' 3 del maggio; e libro rituale di Roviano (sec. XVII) nota tuttavia la processione penitenziale, e le preci che il buon Parroco alternava co' suoi, fin dove da' due diversi punti saliti, si ritrovavano riunite quelle turbe di villici. Che se degli assassini si nascondevano pe' monti, que' devoti passaggi di numerose schiere, e que' cantici di amore fraterno e sacro, doveano senza dubbio fugarli, od obbligarli ad arrendersi: e Roviano, e i vicini luoghi tremano ancora di fuorusciti e briganti.
Trascrizioni di Luca Verzulli















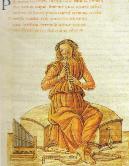


 Sotto i colli signoreggianti la valle, che al trigesimo quarto miglio della via sublacense si estende a dar più libero il corso ai tortuosi giri dell'Anio, prossimo alla moderna strada di Arsoli un ponte si asconde di quadrilateri massi costruito, sul cui strato contavansi venti due piedi e mezzo di lunghezza, di larghezza diciotto; e sul cui arco sembra che gravi un peso di secoli. Scotonico volgarmente si appella, Scutonico lo dissero il Fabretti, il Corsignani, il Revillas ed altri che ne fecero menzione o discorso; sebbene Stratonico denominato lo abbia l'Olstenio. Ma se costui errò forse nella denominanza; non errò ponendolo su quella via, che di mezzo agli Equi fu aperta dal magnanimo lor vincitore; e poscia fin là si protrasse dove Atemo versa il tributo delle sue acque in seno all'Adriatico. E ben numerosi son gli argomenti onde l'eruditissimo Nibby ha saputo riconoscere la Valeria costeggiante l'orrido monte S. Elia, immaginata già dal Fabretti, e da chi mal seguivane in ciò l'opinione, a nullità di prove soddisfacenti, e segno d'immense difficoltà. Certo è che tal ponte mostra già in se stesso confermare che a quella via appartenesse: dappoichè il carro, che certo non l'avrebbe strisciato frequente se fosse stato ponte si un semplice diverticolo alle sorgenti dell'acqua Marzia (siccome conghietturò il Fabretti); e che dovette certo andar frequente per un sentiero di tanta agiatezza e commercio qual fu già la Valeria (gemente sotto i carichi accumulati) solenni vi ha improntate le sue vestigie. È noto peraltro come sulle pubbliche vie, le più frequentate in ispece, volean sepolcro gl'illustri nostri maggiori, onde esposti alla pubblica vista, più sicura che non altrove aspettassero un vale pietoso, cui negar non sapevagli il passaggero. Or da questo costume eziandio difender poteva l'Olstenio una vetusta lapida mortuaria; poi nello Scotonico ad oriente dissotterrata non ha di molto, e del seguente tenore
Sotto i colli signoreggianti la valle, che al trigesimo quarto miglio della via sublacense si estende a dar più libero il corso ai tortuosi giri dell'Anio, prossimo alla moderna strada di Arsoli un ponte si asconde di quadrilateri massi costruito, sul cui strato contavansi venti due piedi e mezzo di lunghezza, di larghezza diciotto; e sul cui arco sembra che gravi un peso di secoli. Scotonico volgarmente si appella, Scutonico lo dissero il Fabretti, il Corsignani, il Revillas ed altri che ne fecero menzione o discorso; sebbene Stratonico denominato lo abbia l'Olstenio. Ma se costui errò forse nella denominanza; non errò ponendolo su quella via, che di mezzo agli Equi fu aperta dal magnanimo lor vincitore; e poscia fin là si protrasse dove Atemo versa il tributo delle sue acque in seno all'Adriatico. E ben numerosi son gli argomenti onde l'eruditissimo Nibby ha saputo riconoscere la Valeria costeggiante l'orrido monte S. Elia, immaginata già dal Fabretti, e da chi mal seguivane in ciò l'opinione, a nullità di prove soddisfacenti, e segno d'immense difficoltà. Certo è che tal ponte mostra già in se stesso confermare che a quella via appartenesse: dappoichè il carro, che certo non l'avrebbe strisciato frequente se fosse stato ponte si un semplice diverticolo alle sorgenti dell'acqua Marzia (siccome conghietturò il Fabretti); e che dovette certo andar frequente per un sentiero di tanta agiatezza e commercio qual fu già la Valeria (gemente sotto i carichi accumulati) solenni vi ha improntate le sue vestigie. È noto peraltro come sulle pubbliche vie, le più frequentate in ispece, volean sepolcro gl'illustri nostri maggiori, onde esposti alla pubblica vista, più sicura che non altrove aspettassero un vale pietoso, cui negar non sapevagli il passaggero. Or da questo costume eziandio difender poteva l'Olstenio una vetusta lapida mortuaria; poi nello Scotonico ad oriente dissotterrata non ha di molto, e del seguente tenore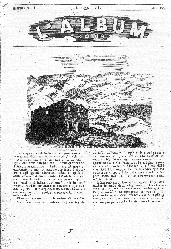 In tempi ne' quali tutto avea religiosa denominazione, più di un monte fu detto di S. Elia. Non si sarebbe avvertito, fino col nome, che di gran lena fosse d'uopo a salirsi, simili quasi a quell'Oreb, alle cui falde il Tesbite ebbe ad essere riconfortato di angelico pane? o che lassù ti si aprirebbe agli sguardi interminato orizzonte, quale già dalle altezze del suo Carmelo al Profeta, e al garzone mandato da lui a spiare sulla punta degli ultimi sassi la simbolica nuvoletta? o che in quelle vette si sarebbe novellamente gustato lo Spirito di Dio, Spirito d'aura leggera, come allora che Elia si coperse il capo del prodigioso suo manto, e disse - ecco Iddio?
In tempi ne' quali tutto avea religiosa denominazione, più di un monte fu detto di S. Elia. Non si sarebbe avvertito, fino col nome, che di gran lena fosse d'uopo a salirsi, simili quasi a quell'Oreb, alle cui falde il Tesbite ebbe ad essere riconfortato di angelico pane? o che lassù ti si aprirebbe agli sguardi interminato orizzonte, quale già dalle altezze del suo Carmelo al Profeta, e al garzone mandato da lui a spiare sulla punta degli ultimi sassi la simbolica nuvoletta? o che in quelle vette si sarebbe novellamente gustato lo Spirito di Dio, Spirito d'aura leggera, come allora che Elia si coperse il capo del prodigioso suo manto, e disse - ecco Iddio?